https://www.ilponterivista.com/shop/prodotto/il-ponte-numero-6-2022/”>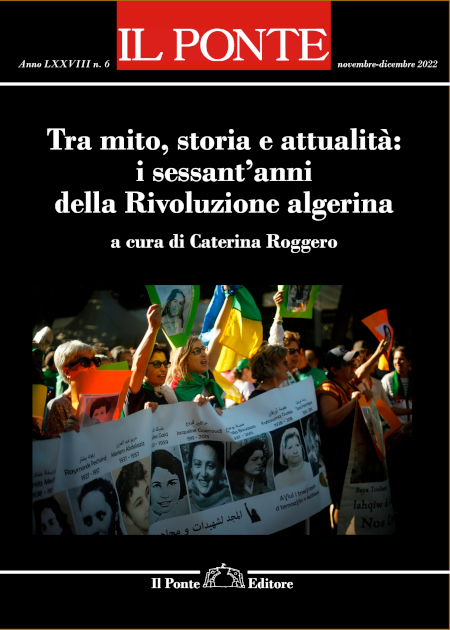
Tra mito, storia e attualità: i sessant’anni della rivoluzione algerina
a cura di Caterina Roggero
Caterina Roggero, Tra mito, storia e attualità: i sessant’anni della Rivoluzione algerina
Francesco Tamburini, Storia e Rivoluzione nei testi costituzionali algerini dal 1963 a oggi
Caterina Roggero, I militari e la politica dell’Algeria dall’indipendenza a oggi
Lorenzo Scala, L’esperienza dello sviluppo socialista nell’Algeria degli anni Sessanta e Settanta: un bilancio
Vermondo Brugnatelli, I Berberi d’Algeria prima e dopo la rivoluzione
Luca Peretti, «La battaglia d’Algeri» di Gillo Pontecorvo, rifiuti e “censure”
Carlo Podaliri e C. Mario Lanzafame, Il taccuino di Silvio Pampiglione (El Bayadh, 1962-1963). Un medico italiano racconta le storie di torturati algerini
Andrea Brazzoduro, Algeria, Francia: una «storia d’amore»? Oltre una memoria nazionalista, colonialista e patriarcale
Jolanda Guardi, La rivoluzione nella letteratura algerina in lingua araba
Paola Caridi, Casbah. La città nuda
Nadira Haraigue, I giovani e il Fln: la disillusione nei movimenti dell’ottobre ’88
Karim Metref, L’indipendenza confiscata. Le lotte per una Algeria libera e democratica dalla guerra di liberazione alla protesta dell’Hirak
Giulia Crisci, «E allora perché non l’ideale folle di una società egualitaria?» Continuare a lottare perché la Rivoluzione si compia
Saadia Gacem, Femminismo e Hirak. Una lotta nella lotta
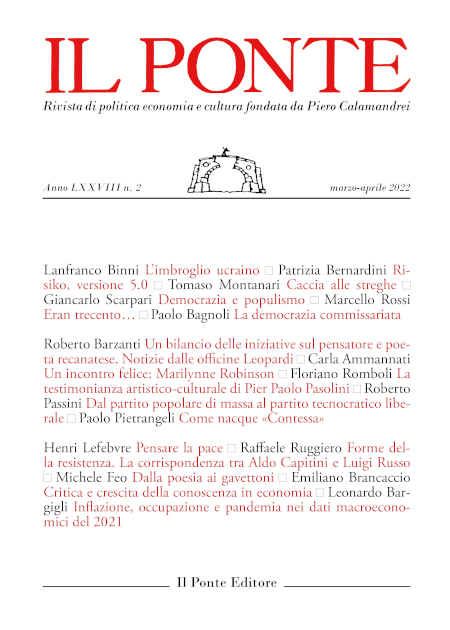
Lanfranco Binni, L’imbroglio ucraino
Patrizia Bernardini, Risiko, versione 5.0
Tomaso Montanari, Caccia alle streghe
Giancarlo Scarpari, Democrazia e populismo
Marcello Rossi, Eran trecento…
Paolo Bagnoli, La democrazia commissariata
Emiliano Brancaccio, Critica e crescita della conoscenza in economia
Leonardo Bargigli, Inflazione, occupazione e pandemia nei dati macroeconomici del 2021
Henri Lefebvre, Pensare la pace
Raffaele Ruggiero, Forme della resistenza. La corrispondenza tra Aldo Capitini e Luigi Russo
Michele Feo, Dalla poesia ai gavettoni
Paolo Pietrangeli, Come nacque «Contessa», con una presentazione di Giampaolo Borghello
Roberto Barzanti, Un bilancio delle iniziative sul pensatore e poeta recanatese. Notizie dalle officine Leopardi
Carla Ammannati, Un incontro felice: Marilynne Robinson
Floriano Romboli, La testimonianza artistico-culturale di Pier Paolo Pasolini
Roberto Passini, Dal partito popolare di massa al partito tecnocratico liberale
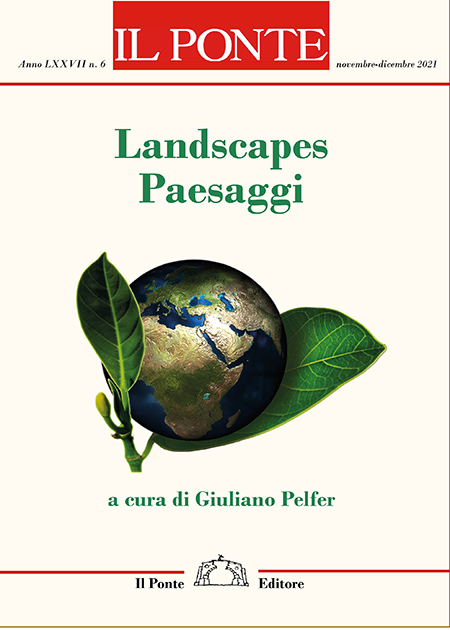
Landscapes
Paesaggi
a cura di Giuliano Pelfer
Giuliano Pelfer e Marcello Rossi, Questo speciale
Giuliano Pelfer, Sul concetto di landscape e sulla sua storia
Philippe Descola, Landscape come trasfigurazione
Angelo Baracca, Cyber-landscape, intelligenza artificiale e guerre
Sergio Luzzi, Chiara Bartalucci, Sara Delle Macchie, Vie En.Ro.Se. Ingegneria S.r.l., Paesaggi sonori: identità del tempo e dello spazio
Elisa Nocella ed Enrico Alleva, Fatti e misfatti del concetto di adattamento biologico
Maria Laura Giacobello, Il Prometeo “imprevidente”. Nuove vie per una saggezza antica
Delio Salottolo, Paesaggi dell’antropocene tra creazione e lacerazione: è ancora possibile una rivoluzione simbolica e politica?
Enzo Ferrara, Visioni per il prossimo millennio: umanità e scienza in prospettiva sostenibile
Giuliano Pelfer, Dalla Landscape Archaeology all’ecologia storica: verso una strategia di ricerca integrata sul cambiamento globale
Enzo Ferrara, L’imbarazzo di doversi estinguere
Angelo Baracca, Guerre e ambiente
Pier Giorgio Ardeni, Di paesaggi, pandemie e degli effetti dello sviluppo
Maurizio Pallante, Disegnare le città per il ventunesimo secolo
Michele F. Fontefrancesco, Paesaggio tra abbandono rurale e continuità
Maurizio Pallante, Agevolare, in punta di piedi, il ripopolamento delle aree interne
Gregorio Taccola, Il cavaliere dell’Apocalisse alla foce del fiume Magra: domande e metodologie di una ricerca-azione per lo studio integrato del territorio
Giuliano Pelfer, Piergiovanni Pelfer, Marcello Rossi, Ragioni e modalità di un progetto per un Landscapes Evolution Observatory (LEO)