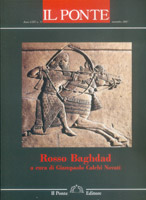 Molti definiscono la guerra americana (o anglo-americana) contro l’Iraq di Saddam Hussein un errore. Anche al Congresso di Washington. Anche sui giornali che riflettono gli interessi dell’establishment. Paradossalmente, si protesta piú in alto che in basso da quando le sinistre europee, soprattutto se al governo, si trincerano dietro il realismo, le alleanze, gli impegni assunti in questa o quella sede per non vedere e non sentire e l’opinione pubblica ha cessato di essere quella «seconda potenza» che il «New York Times» indicò a suo tempo come solo contraltare all’egemonismo americano.
Molti definiscono la guerra americana (o anglo-americana) contro l’Iraq di Saddam Hussein un errore. Anche al Congresso di Washington. Anche sui giornali che riflettono gli interessi dell’establishment. Paradossalmente, si protesta piú in alto che in basso da quando le sinistre europee, soprattutto se al governo, si trincerano dietro il realismo, le alleanze, gli impegni assunti in questa o quella sede per non vedere e non sentire e l’opinione pubblica ha cessato di essere quella «seconda potenza» che il «New York Times» indicò a suo tempo come solo contraltare all’egemonismo americano.
Non è difficile capire perché a quattro e piú anni dal passo fatale compiuto dal presidente Bush e dai suoi complici nel marzo 2003 si tenda a prendere le distanze da una guerra fallimentare. Troppe bugie. Il disprezzo per le forme ha impedito un’adesione piú vasta nel mondo. Blair e Berlusconi, o i molti dirigenti dell’Europa dell’Est alla ricerca di una vendetta “storica”, non potevano bastare a migliorare la performance di George W. nelle vesti dell’«uomo solo» allo sbaraglio: solo con l’idea fissa di sfruttare al massimo l’11 settembre, con gli spettri aleggianti in casa Bush e i calcoli fra avventuristi e lucrativi dei Cheney e dei Rumsfeld. La scissione fra gli Usa e una parte significativa dell’Europa indebolisce tutto l’Occidente, impegnato per suo conto in una sfida da cui dipende la salvaguardia del suo modello di vita (in pratica, anche se non tutti sono disposti ad ammetterlo, dei suoi privilegi). Ma anche troppe decisioni sbagliate. L’esercito iracheno non andava sciolto all’improvviso dopo la sconfitta sul campo. E cosí non aver preparato in tempo l’infrastruttura per gestire il dopo-Saddam, non aver pensato alla probabile insorgenza o resistenza di popolo o di fazioni che sarebbe scoppiata, ecc. Lo stesso Baath poteva essere recuperato, dopo l’inevitabile “epurazione”, affinché il vuoto di potere, specialmente a livello locale e intermedio, fosse almeno in parte compensato dalla presenza di un apparato collaudato e di un’infrastruttura con i collegamenti trasversali che sono necessari a qualsiasi governo. Soffiare sul fuoco degli antagonismi etnici, religiosi e clanici, sciiti e curdi contro sunniti, laici contro religiosi e religiosi contro laici, separatisti o regionalisti contro centralisti, non poteva portare a nulla di buono. L’argomento principale che viene invocato da piú parti contro il ritiro delle forze d’occupazione («dopo di noi il diluvio») è di fatto la piú bruciante condanna della guerra. Il rischio è invece che tutto si riduca a lamentare l’errore di non aver tenuto conto del consiglio del grande storico libanese Kamal Salibi: «Le grandi potenze non dovrebbero mai lasciarsi coinvolgere nella politica di piccole tribú».
Scritti di: Alberto Benzoni, Marco Calamai, Giampaolo Calchi Novati, Maurizio Cremasco, Teresa Filomena, Mirella Galletti, Elisa Giunchi, Marco Maestro, Anna Maria Medici, Mario Nordio, Valeria Poletti, Farian Sabahi, Simona Torretta.


